Tutti i diritti delle pubblicazioni contenute in questa pagina sono riservati, non si possono scaricare, copiare, riprodurre i testi senza autorizzazione. Se hai bisogno di prenderli in prestito per utilizzi leciti e citando l’autore, scrivi a barbarapavan469@gmail.com
PUBBLICAZIONI:
LUCIA BUBILDA NANNI – “ORAMA”
di Barbara Pavan
ORAMA è un suffisso che rimanda tanto alla veduta quanto alla proiezione e suggerisce che per vedere con consapevolezza sia necessario esplorare anche il verso delle cose, l’ombra. È questo ‘doppio’ a rivelare la mutevolezza, l’impermanenza e la vera natura di ogni manifestazione visibile, la pluralità del reale che una osservazione superficiale, un solo punto di vista, non può restituire.(…)
Articolo integrale pubblicato su GRAPHIE n.106 Anno XXVI 2024
FABIA DELISE
testo critico catalogo di Barbara Pavan
La ricerca di Fabia Delise esplora le possibilità di sintetizzare una pratica antica con un linguaggio contemporaneo. Per affrontare questa sfida ha affinato nel tempo diverse tecniche – dal ricamo all’art quilt – fino a padroneggiarle magistralmente e con impeccabile precisione.
Questo investimento formativo è stato necessario per consentirle quella sperimentazione che, nel perimetro di una tradizione che intende non solo preservare ma anche trasmettere al futuro, trasforma la lentezza e la ripetitivà anacronistica dei gesti in un esercizio meditativo talmente arcaico da sovrastare il tempo rendendolo più che mai moderno e rivoluzionario in una contemporaneità dai ritmi di una velocità sconcertante. Per comprendere a fondo il lavoro di Delise bisogna partire da qui, dalla dicotomia di fenomeni apparentemente opposti e dalla sua capacità di coniugarli in un linguaggio nuovo, intimista, atemporale.
THOMAS DE FALCO: ELOGIO DELLA METAMORFOSI
di Barbara Pavan
Enfant terrible della tessitura se è vero, com’è vero, che già all’epoca in cui frequentava la Scuola Superiore di Arazzo del Castello Sforzesco a Milano le sue opere forzavano la bidimensionalità proiettandosi verso la terza dimensione e trasformandosi, a tutti gli effetti, in sculture, Thomas De Falco è, a mio parere, tra gli artisti che utilizzano i linguaggi tessili e in particolare le tecniche dell’arazzeria, uno dei più interessanti sulla scena internazionale. Classe 1982, italo-francese, oggi è rappresentato dalla Galleria Richard Soulton di Londra ma vive tra Parigi e il resto del mondo, in un nomadismo che, come tutto in lui è innato, naturale, fluido. Quest’ultima caratteristica – la fluidità – è forse il fil rouge, il tratto comune a tutta la sua esistenza: permea la sua ricerca, la sua pratica artistica, la sua stessa identità.
DIRE, FARE, CUCIRE: FLORENCIA MARTINEZ
di Barbara Pavan
Per comprendere a fondo il lavoro di Florencia Martinez occorre partire dalla sua biografia. Nata e cresciuta in Argentina da una famiglia per metà di origine italiana e per l’altra metà spagnola e irlandese, dal 1990 si è trasferita a Milano dove vive e lavora ancora oggi. Nel ramo materno assorbe l’inquietudine generata dal rapporto conflittuale dei nonni con la terra che ha dato loro i natali e che hanno abbandonato alla ricerca di migliori condizioni di vita nel paese sudamericano dove, in effetti, in quegli anni molti trovano benessere e prosperità. Nei confronti dell’Italia lontana, un po’ matrigna avara e ingrata, in famiglia si nutrono sentimenti contrastanti: è l’incantevole altrove ma anche le radici imbarazzanti, è il luogo di cui “non ne voglio più sapere” ma anche quello della lingua sacra delle preghiere. Una tensione che l’artista, non senza ironia, ci restituisce nell’immagine delle feste natalizie della sua infanzia celebrate a tavola con cotechino e lenticchie nelle bollenti estati di Buenos Aires. Del ramo paterno, poi, Martinez racconta di una nonna irlandese morta come Dylan Thomas, ‘dopo il diciottesimo bicchiere di whisky’, e di un nonno Martinez che pare sia stato un avventuriero spagnolo durato il tempo di un drink.
ANATOMIA DELLE RELAZIONI UMANE. LA RICERCA ARTISTICA DI GIULIA NELLI
di Barbara Pavan
La ricerca di Giulia Nelli si snoda attraverso la complicata rete delle relazioni umane all’interno di quella che Zygmunt Bauman definiva società liquida. Fluidità di rapporti affettivi ed emotivi generata da una cultura del consumo e del soddisfacimento immediato di bisogni e desideri, in cui ogni cosa, ivi incluse le relazioni, deve essere pronta, consumata, sostituita. In una società sempre forzatamente in movimento, incapace di attribuire valore al tempo dell’attesa, coltivare relazioni è indubbiamente complicato, tanto che è forse più adeguato, in quest’era ipertecnologica, parlare di connessioni ovvero relazioni virtuali che, a differenza di quelle di un tempo, sono facili da instaurare e altrettanto da troncare.
Uno scenario di vita liquido, appunto, quello moderno che ha in sé un’ambivalenza – si instaurano rapporti per sfuggire al senso di vulnerabilità e solitudine ma volendo preservare altresì intatta la propria libertà – dalla quale risultano legami fragili la cui estrema precarietà genera un senso di insicurezza. La Nelli riassume questa tensione tra attrazione e repulsione, tra speranza e paura nel binomio legàmi/légami con cui affronta due ampie tematiche: la complessità dei legami che si instaurano tra le persone – il loro perdurare anche soltanto nella memoria, la carica emotiva che sviluppano e l’influenza che hanno sulla vita interiore dell’individuo – e la rete di relazioni che compone una comunità.
LA NATURA BUGIARDA DI ELHAM M. AGHILI
di Barbara Pavan
Lavora alacremente al nuovo progetto, Elham M. Aghili, con pazienza certosina e perizia tecnica coltivata e maturata dopo tanta sperimentazione e continui ritocchi migliorativi. Ha da poco terminato la grande installazione in mostra – mentre scrivo – a CONTEXTILE, prestigiosa Biennale di Arte Tessile Contemporanea di Guimarães, in Portogallo, che l’ha selezionata attraverso un contest a cui partecipano artisti da tutto il mondo. La serie di opere che sta lentamente prendendo forma invece sarà in mostra a Bologna il prossimo giugno, salvo slittamenti dovuti ad eventuali nuove emergenze. Il progetto trae ispirazione dalle piante del Giardino dei Semplici, il primo orto botanico di Bologna, voluto da Ulisse Aldrovandi (1522-1609) – filosofo, naturalista, botanico, entomologo – e richiama altresì le teorie di Johann Wolfgang Goethe espresse nel suo ‘La metamorfosi delle piante’. Qui nell’affrontare il tema del divenire della forma in natura, lo scrittore tedesco ipotizza che le differenti specie botaniche si siano evolute da una pianta madre, un processo perennemente in fieri in cui le nuove varietà mantengono una connessione con le piante generatrici. Partendo da questa idea, la Aghili sta sviluppando un giardino tessile in cui ciascuna pianta appare ‘generata’ da quella adiacente, un ibrido nella forma, seppur identificabile dai molti accurati dettagli che contraddistinguono tutte le sue opere. È dunque una natura in continua evoluzione quella realizzata da questa giovane artista italo-iraniana, laureata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, capace di trasformare il filo di lana, elemento fluido, morbido, esile, in un materiale solido e corposo di cui si serve per creare installazioni tridimensionali, talvolta immersive, talaltra invasive (come la natura vera, del resto).
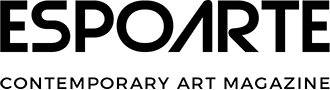
SUL FILO DEL NOSTRO TEMPO, DA CASERMARCHEOLOGICA LA FIBER ART RACCONTA L’OGGI
Intervista a Barbara Pavan di Matteo Galbiati
Appunti su questo tempo – la grande mostra allestita a Sansepolcro (AR) negli spazi suggestivi di CasermArcheologica – ci offre l’opportunità per poter approfondire le tematiche, i contenuti e le modalità espressive di chi ha scelto di esprimersi attraverso il linguaggio della fiber art e, così, abbiamo deciso di raccogliere la testimonianza diretta di Barbara Pavan, una delle massime voci storico-critiche in questo ambito. Pavan, che è anche la curatrice della mostra, da anni si dedica, infatti, esclusivamente allo studio, all’analisi e alla promozione di quegli artisti che, a livello internazionale, hanno scelto di esprimersi attraverso l’arte tessile.

OPEN DIALOGUES: INTERVISTA CON BARBARA PAVAN
Intervista di Margaret Sgarra per TheFemaleCurators
Nata a Monza e cresciuta a Biella tra telai e filati, Barbara Pavan è una curatrice e critica d’arte specializzata in fiber art. La passione per il filo l’ha portata a ideare e curare mostre, progetti espositivi, cataloghi e blog tematici, diventando così un punto di riferimento delle forme espressive tessili.

7 DOMANDE CHE TUTTI FANNO SULL’ARTE TESSILE, CON BARBARA PAVAN
Intervista di Guido Nosari per NonSoloWork
L’arte tessile, o “Fiber art”, è una corrente dell’arte contemporanea che sta diventando sempre più conosciuta e apprezzata da musei e collezionisti.
Per il grande pubblico, invece resta tuttora spesso sconosciuta e poco approcciabile.
Oggi abbiamo deciso di fare 7 domande introduttive a una delle più importanti voci italiane per l’arte tessile, Barbara Pavan.
Già precedentemente abbiamo affrontato l’arte tessile con l’intervento “Nuvole Solitarie” avvenuto a Bergamo, oggi invece solletichiamo la curiosità dei nostri lettori con le domande che più spesso si sentono fare dal grande pubblico.

ARTE TESSILE IN ITALIA
Intervento di Barbara Pavan a LE ARTI POSSIBILI
Nell’incontro pubblico “La possibilità del limite” che si è tenuto sabato 21 ottobre 2023 nei giorni dell’esposizione dell’installazione collettiva GIROTONDI | CROMIE CONDIVISE, Barbara Pavan – curatrice e critica d’arte specializzata in Fiber Art – ci ha proposto le sue riflessioni sul rapporto tra Fiber Art e limite.





